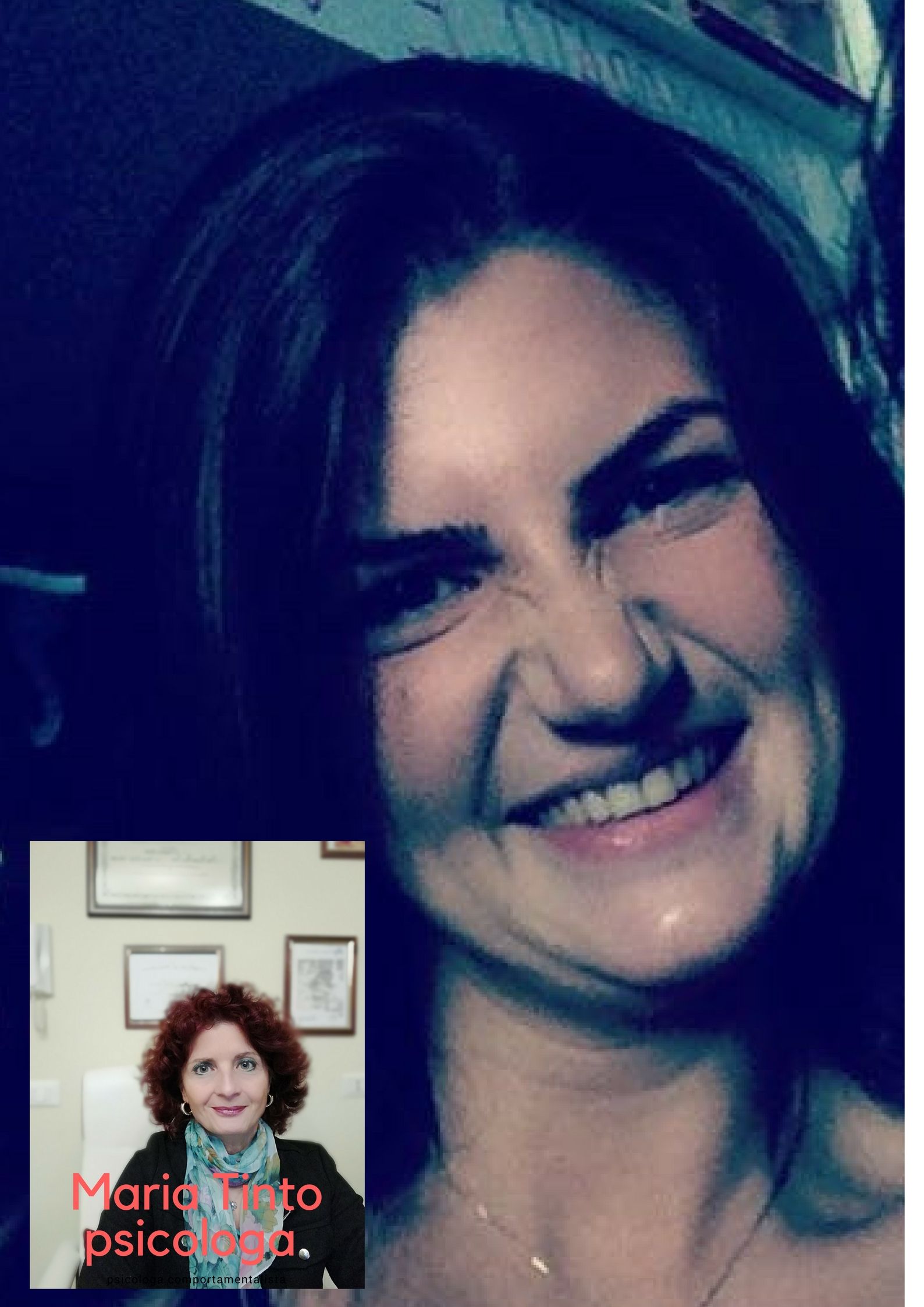Giada De Filippo è la studentessa molisana che si è tolta la vita lunedì 8 aprile, gettandosi da un palazzo dell’Università Federico II di Napoli, dove era andata con tutta la sua famiglia e il fidanzato per discutere la tesi di laurea in Farmacia.
La “laureanda” aveva scelto il pranzo al ristorante e il papà – maresciallo dei Carabinieri in congedo – aveva già prenotato e invitato amici e parenti.
E poi il tailleur, il parrucchiere e il sorriso emozionato di una studentessa che finalmente conclude dopo anni di studi ed esami il percorso complesso e impegnativo.
Il fidanzato con le rose rosse in una mano e con l’altra il cellulare per rintracciarla quando si era allontanata dall’aula dell’ateneo partenopeo, dove sarebbe dovuta essere proclamata dottoressa e incoronata di alloro.
Mentre squilla il telefono, Giada è già sul tetto e risponde al giovane dicendo “guarda su”.
Poi la tragedia.
Il bisogno di capire è forte, da genitori, da adulti, da persone che sono stati studenti, ragazzi e figli.
Abbiamo chiesto alla esperta comportamentalista e psicologa Maria Tinto, autrice di “I bambini non nascono cattivi”, cosa abbia spinto la giovane ad una fine così assurda e, sopratutto chi fosse Giada.
“Giada aveva creato una storia che non era la sua, viveva come in un sogno la vita di qualcun altro. Mi chiedo se le fosse mai stato chiesto qual era il suo sogno o la sua fantasia più bella, da poter realizzare, rispetto alla sua vita.
Giada è una giovane donna che non accetta il fatto di poter fallire, di poter essere considerata un fallimento da coloro che le sono accanto, e di non essere all’altezza nell’interpretare quell’ideale che le era stato cucito addosso. Un ideale frutto di una matrice educativa “giudicante”, che rispecchia il mito della “perfezione” a tutti i costi, un mito che non concede appelli, ma solo sentenze.
Giada “crea” allora una storia, dove lei stessa funge da protagonista, mistificando la realtà con la finzione, come in un’abile passo di danza, unico momento in cui le è possibile dirigere la musica della sua vita e sentire di avere un ruolo, di esserci.
Al di là di quelle che potrebbero essere state le dinamiche familiari, che fanno da sfondo a questa tragedia, è importante ribadire che i figli non vanno mai giudicati nel bene e nel male. Perché anche esprimere giudizi di merito produce, paradossalmente, l’effetto controproducente di creare aspettative che, quando non vengono soddisfatte, portano i figli a considerarsi un fallimento.
I figli sono persone, persone che vanno rispettate dai genitori prima ancora che questi ultimi possano considerarli figli. Rispettare un figlio non vuol dire aderire alle sue richieste economiche o di rappresentazione sociale, ma è qualcosa di molto più profondo, perché vuol dire riconoscergli la possibilità di sbagliare, di non essere perfetto, di aspettare i suoi tempi anche se non sono i propri, di concedergli le opportunità, opportunità di studio, di carriera, di cultura, ma senza alcuna forma di costrizione, né di ricatto. Rispettare un figlio è un lavoro di intarsio, che si comincia a cesellare già prima della sua venuta al mondo. Un lavoro che si costruisce nel donare la libertà al figlio, ancor prima di averlo tenuto tra le braccia. Il dono della libertà, è questo il vero dono che un genitore può fare al figlio.
La sciagura di Giada non è un fatto privato, ma è un fatto che riguarda tutti noi. Si, tutti noi, che inseriti in questo contesto sociale, produciamo queste disgrazie, senza darci la possibilità di riflettere sulle nostre stesse responsabilità, come genitori, come insegnanti, come istituzione.
L’Università, paradossalmente, non è più un luogo di cultura, ma un velodromo, dove la competizione può essere pericolosa, quando non si hanno sufficienti strumenti per fronteggiarla.
Un genitore adeguato al compito genitoriale che si è dato, ha il dovere di fortificare il figlio a non subire nessuna forma di discriminazione da parte degli altri e del mondo che lo circonda.
Giada era fragile? Si sentiva inadeguata? Aveva paura di non essere accettata? Non lo sapremo mai. Possiamo solo constatare quanto fosse sola, nonostante vivesse una vita di “relazioni”, che comunque non l’hanno protetta in nessun modo, perché Giada era sola da anni ed è stata lasciata sola a mettere in atto la sua messinscena, fino alla fine.
Chi scrive un epilogo così funesto della propria vita, sa di lasciare una condanna in chi resta e Giada, col suo gesto, ci ha condannati tutti.
Si, perché siamo tutti condannati. Condannati a doverci domandare se stiamo facendo qualcosa che possa offendere o scalfire la sensibilità di un altro, se stiamo vivendo una relazione rispettosa, se siamo noi stessi degni del ruolo che, da adulti consapevoli o meno, abbiamo scelto di interpretare”.
Marina Cozzo